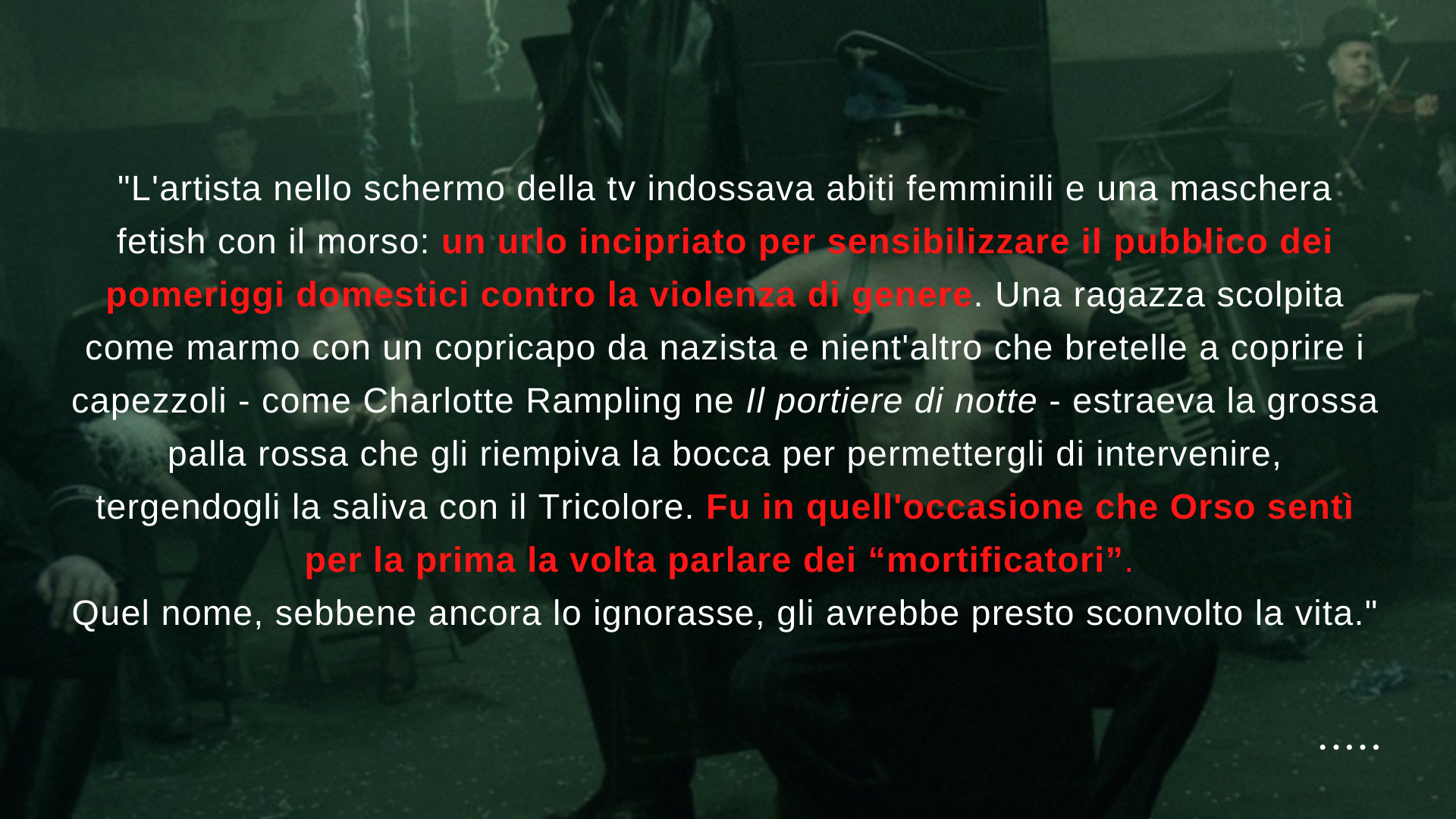“Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them.”
1945, Open society and its enemies, KARL POPPER
Non potevo sapere che un cuore di cane è la disgrazia più grande,
2004, Cuore di cane, KAFKA
non potevo sapere che un cuore di cane è la colpa più forte.
Giulio, dopo anni e anni, aveva finito per crederci che il punk non fosse altro che un genere musicale o, al limite, una fase necessaria di rottura in cui gli adolescenti costruiscono la propria identità nel mondo, per contrasto. Siamo quello che siamo, in fondo, perché abbiamo fatto delle scelte in opposizione a quello che era l’autorità costituita. Sia che essa fosse rappresentata dai genitori e dai loro canoni estetici e morali, sia che essa trovi forma in una qualsiasi delle istituzioni del sistema a partire dalla scuola per finire con la Chiesa.
E così, complice la pandemia degli anni Venti che rivoluzionò la vita sociale, un buon lavoro come educatore che lo portò a sporcarsi le mani nella vita reale e del tutto scollegata dagli idealismi della militanza, una moglie che amava sinceramente (e i quattro figli tutti voluti e cercati) e finanche la anch’essa autentica convinzione che oggettivamente il sistema in cui vivevano, andava distrutto dalle basi e ricostruito, Giulio C. dimenticò presto la sua chitarra elettrica in cantina e fu uno dei primissimi sostenitori della dottrina del buonsenso di Michail “Huxley” Woland.
Una soluzione razionale e misurabile che, dati alla mano, valicava qualsiasi potere precostituito era la “cosa” più vicini all’anarchia che quell’uomo, ferito dalle brutture del mondo e deluso dalle ideologie, avesse mai sperimentato. Perché se è vero che amava moltissimo i suoi figli, era altrettanto vero che il suo stipendio poteva garantire una vita adeguata e un’istruzione prestigiosa solo ai primi due. Il terzo e il quarto erano “arrivati” per pura irrazionalità. E quella folle gioia di volersi circondare di figli amati e felici, in un mondo pieno di bambini sfruttati, picchiati, traumatizzati o semplicemente cresciuti da idioti, aveva portato ad una serie di rinunce (sua moglie, per esempio, non ricominciò più a lavorare) e di sacrifici che contribuirono alla crisi sfociata in un divorzio lampo.
Con la fine dell’epoca delle Democrazie Apparenti e della dittatura dell’Emotività, era sufficiente portare un test della compatibilità per ottenere, seduta stante, l’annullamento di ogni matrimonio stipulato prima delle riforme.
Dopotutto il mondo era allo sbando. Famiglie ignoranti e indigenti sfornavano cucciolate di futuri schiavi che non potevano mantenere, condannandoli ad un futuro sieropositivo, intanto che il ricco Nord cresceva piccoli psicopatici fascisti, dando loro in dote armi da fuoco e ansia.
Ma questo era il passato, ora, ad una coppia con una bassa compatibilità genetica atta alla procreazione viene consigliato di ricorrere all’adozione, di uno dei tanti bambini, che vengono portati via da quelle famiglie incapaci di mantenerli o crescerli, a causa di scarsa intelligenza, cultura o reddito e che hanno concepito senza l’avallo del sistema sanitario nazionale.
Sia ben intenso: non è vietato procreare in quei casi ma è sconsigliato e il buonsenso insegna che quando si prendono decisioni avventate, dettate dall’emotività o dall’arroganza che trascende il sapere scientifico ed empirico, si deve essere, di conseguenza, responsabili in toto delle proprie scelte. Niente sussidi, parchi giochi inclusivi, permessi speciali sul lavoro, insegnanti di sostegno, accesso alla sanità pubblica, bonus fiscali o altre forme di accatto. Un antico adagio diceva qualcosa del tipo “hai voluto la bicicletta? E ora pedala”. Niente pedalata assistita per chi non accoglie il buonsenso nella propria vita, cittadino.
D’altronde era finita da molto tempo l’ossessione, tipica dell’epoca delle Democrazie Apparenti, di dover sovrappopolare un pianeta già al limite di sopportazione. L’istinto materno era stata un’invenzione inculcata nella mente delle classi meno abbienti in quei tempi irrazionali in cui, l’avidità dei padroni, voleva forza lavoro da impiegare nelle fabbriche, nei campi e carne da macello per le guerre e i lavori degradanti o logoranti.
Facendo loro credere che l’ultralavoro e i sacrifici servissero per far vivere meglio i propri eredi, come in una sorta di martirio religioso pregno di ricompense ultraterrene, ma non godibili a breve termine nel qui e ora, essi obbedivano e si moltiplicavano. Una volta insegnato il buonsenso anche nelle scuole e smontata la mitologia e le credenze superstiziose legate all’istituzione della famiglia, il problema della sovrappopolazione svanì e così la carenza delle risorse e la loro distribuzione che divenne finalmente equa.
La non-logica del profitto capitalista, aveva raggiunto un tale livello di sclerotizzazione, che aveva fatto il giro su se stessa in un loop auto-cannibale. Un avido uroboro che tutto consuma e tutto distrugge nel tentativo di mangiare persino la propria coda.
Nel nord del mondo si moriva di malattie debellate da secoli o per un acquazzone improvviso, sommersi nel fango e nella propaganda anti-scientifica. Nel Sud del mondo si moriva in campi di concentramento fatti di mattoni e fondamentalismi religiosi, avallati esplicitamente – i primi – e in modo subdolo i secondi, dalle antiche democrazie al di qua del Mediterraneo.
In un mondo che si definiva laico, la gente aveva smesso di lapidare le donne adultere, ma era disposta a credere a qualsiasi cosa pur di non sentirsi l’inutile merda sfruttata, la cui vita ruotava attorno alle dieci ore lavorative giornaliere e a famiglie focolai di nevrosi e aspettative deluse.
Le azioni politiche e i movimenti per i diritti della comunità LGBTQ+, dei neri e delle donne avevano soltanto alzato la posta in gioco, portando il conflitto persino tra le mura domestiche. E ai fascisti che rimpiangevano la dittatura, ma si sentivano vittime nel momento in cui gli si diceva che era meglio non dire negro o troia a chi taglia la strada, non andava bene neanche che fosse un frocio a comandare sul lavoro e nell’esercito o ad operarli in un ospedale.
E in quella zattera alla deriva, tormentata dalle tempeste, in cui la percentuale di suolo calpestabile era in deficit perenne, con l’acqua alla gola, erano pronti a sacrificare il più debole in nome della propria libertà, dandogli fuoco. Fuoco nei locali LGBT+ e fuoco nelle sedi anarchiche. Fuoco nei centri di accoglienza dei migranti. Fuoco alle Case delle Donne. Fuoco alle automobili di chi osava condannare la violenza, senza però sacrificare il bon ton e l’autoinganno del pluralismo. Fuoco a chi voleva dar loro fuoco. Un fuoco distruttore, che voleva abbattere ogni ostacolo alla loro libertà di esercitare il proprio privilegio su questa terra.
Ma la libertà è qualcosa che non si può misurare. La libertà è soltanto un’idea che può essere mal interpretata anche delle più semplici e pure delle menti. E per Giulio, tra accettare la loro “libertà” violenta di opprimere, sfruttare e depredare o affidarsi alla logica iper pragmatica dei sostenitori della prima ora di Woland, scelse il male minore e aderì con convinzione alle prime iniziative indette dalla Woland Corporation. Perché un mondo privo di amore è, però, anche un mondo libero dall’odio.
La calma, la stabilità e l’efficienza dettati dal buonsenso erano un ottimo compromesso a cui ambire nel nome delle fotocopie sbiadite dei simulacri di quelli che erano i suoi valori in giovinezza.
Eppure il divorzio da Diana era stato devastante. Seppur comprendesse le motivazioni razionali che l’avevano spinta a chiedere l’annullamento del matrimonio, il suo dolore era così tangibile. Non vi era alcun coefficiente che potesse esplicitarlo, ma era vero, maledizione, come è vero il caldo del sole bollente nel deserto e il gelo degli inverni nelle terre del permafrost. E se nessuno poteva misurarlo, come un termometro misura i 50° gradi nel Sahara e i –70° della lontana Yakutsk perché forse qualcuno doveva ancora inventarlo uno stramaledetto termometro capace di farlo!
E non c’era incontro con partner compatibili al 100% o pratiche meditative di induzione al buonsenso, che potessero alleviare quel dolore provocato dal non potersi svegliare accanto a lei e in mezzo al caotico vociare dei suoi figli. Come puoi tradurre in numeri la differenza tra nutrirti e mangiare o misurare in centimetri quel vuoto nello stomaco, causato dal vedere un frigo in cui mancavano i succhi di frutta che piacevano al più piccolo o i gusti di birra che Diana comprava sapendo di fargli un piacere? La loro assenza era un assedio a cui lui sentiva di doversi ribellare. Perché il dolore è qualcosa che non si deve subire. Bisogna dichiarare guerra alla disperazione con ogni arma in nostro possesso.
Fu durante il trasloco di Diana e i piccoli, che si trasferivano dal nuovo compagno di classe superiore, che la vide in un angolo della cantina: la sua Yamaha Pacifica nera e quell’adesivo “This machine kills fascists” e si ricordò all’improvviso che già in passato aveva provato quel dolore così intenso e che quella chitarra ne era stata la cura.
Nei mesi successivi abbandonò ogni attività extra-lavorativa offerta dalla Corporazione Sociale per cui lavorava e aspettava che i vicini di casa si chiudessero nei loro appartamenti, per scaricare in cantina le assi di legno, i pannelli di polistirolo e la lana di roccia. Ci aveva messo delle settimane per prendere tutte le misure al millimetro per farsele tagliare dall’addetto del Centro Fai da te. Si giustificò dicendo che voleva soppalcare una stanza per creare un’area adibita alla meditazione al buon senso e il commesso annuì senza neanche ascoltarlo. Nessuno lo aveva mai fatto, d’altronde.
Non era stato difficile creare la parete in cartongesso a pochi centimetri da quella esistente, riempire l’intercapedine di lana di roccia, e rivestire tutto con i pannelli fonoassorbenti. La vera impresa fu trovare la strumentazione necessaria per poter mettere in piedi un piccolo studio di registrazione con tutto il set necessario. Impiegò settimane per trovare amplificatori sfondati, batterie gonfie di muffa e umidità e un mixer sdentato per poi smontarli, smembrarli e ricostruirli, mischiando e assemblando i pezzi tra loro. Comprava tutto online dai collezionisti, cambiando ID di volta in volta, e usando persino quello dei suoi figli. Doveva essere impazzito! Eppure portò a termine lo studio e gli bastò una manciata di settimane per scrivere e registrare decine e decine di canzoni. Era come un fiume in piena. Riff dopo riff, assolo dopo assolo. Una diga aperta all’improvviso che custodiva quasi un ventennio di sentimenti repressi, emozioni sedate e parole non dette. La parole… ecco, quelle mancavano.
Lui si era sempre espresso attraverso il suono della sua chitarra, riconoscibile fin dal primo accordo che era una sorta di lamento o un ululato che portava in sé la memoria del branco. Quando lui suonava, fuori, era tutto silenzio. E poi c’era Guenda, sintonizzata su quell’ululato, capace di tradurlo in testi che erano artigli che sibilano nell’aria, prima di conficcarsi nella carne. La timida Guenda, che i primi tempi dava le spalle al pubblico, perché non riusciva a cantare guardandoli in faccia.
«Come fai ad essere timida e scrivere queste cose?» le aveva chiesto un giorno.
«Io non sono timida, ma mi vergogno della rabbia che ho dentro» aveva risposto, salendo sul palco di quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto, in cui avrebbe trasformato quella rabbia in luce.
Quando si tolse la vita, a pochi giorni dal suo arresto durante un concerto proibito, nonostante il virus fosse stato debellato ed era cessata la pandemia ma non le misure repressive, scrisse che quello che faceva quando saliva sul palco e urlava dentro un microfono, non aveva nulla a che fare con la musica, ma era una questione di sopravvivenza e di resistenza alle brutture del mondo in cui vivevano.
Troppo sensibile per scegliere la violenza e la lotta, non le rimaneva altro che fagocitare tutta quella rabbia e quel dolore – suo e di chi stava sotto il palco – in ogni respiro che le gonfiava la pancia, prima di attaccare a cantare.
Era stata lei a regalare a Giulio quell’adesivo. E a lei dedicò i 5 pezzi strumentali che registrò in una sorta di demo di ciò che rimaneva dei “This machine” e, proprio nel momento in cui pensava di cercare Monica e Panatta per farglielo sentire, venne contattato da una giovane ragazza di nome Dorotea che voleva parlargli.
Si presentò come una ex dipendente della Woland Corporation, una disertora caduta in rovina, a causa di un certo suo studio che non era piaciuto ai piani alti. Raccontò a Giulio ciò che aveva in mente e lui, ben sapendo a cosa stavano andando incontro, accettò e le mostrò subito la sala prove suonando per lei alcuni dei brani che aveva composto.
«Sei consapevole che rischiamo di essere arrestati, vero?» chiesi.
Sì, Giulio lo sapeva ma non gli importava nulla, perché da quando quella giovane ragazza con la faccia da matematica gli aveva parlato, aveva smesso di pensare a Diana. Ed era un segno. Non poteva essere un caso se dopo tutto quel lavoro, senza nessuna motivazione o ragione evidente, fosse arrivata lei a rendergli manifesto quel desiderio inconscio a cui non riusciva dare una forma, ma era sempre stato lì, nei suoi pensieri, da quando Diana lo aveva lasciato. E forse anche prima, non poteva esserne certo.
Ormai non aveva nulla da perdere ed era disposto anche ad accettare che Fausto rientrasse nella sua vita e, con lui, il ricordo doloroso di Guenda e della sua morte ingiusta. Non era mai stato così convinto di qualcosa in tutta la sua vita.
«Sì, lo so che rischiamo l’arresto» rispose, con una risata che continua a risuonarmi nelle orecchie come una tortura.